|
|||
|
| |||

|
|||
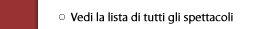 |
|||
Nuova stagione con Ardenzi |
||
 |
||
La Lupa, di Giovanni Verga. Che c’entravo io, trentina, un po’ intellettuale, con questa siciliana sfrenata, accecata di sesso, un animale, una lupa appunto, ma una lupa in calore che perde la testa per il giovane Nanni Lasca, gli fa sposare la figlia per tenerselo vicino e si avvia alla inevitabile conclusione sanguinosa? Niente, diciamo la verità.
 Però ebbi un’idea mica male, che incontrò l’approvazione di Ardenzi e del regista, Lamberto Puggelli. Riportarmi cioè all’archetipo della passione di una donna matura per un uomo molto più giovane . Pensai a Fedra e a Ippolito. E scelsi la Fedra di D’Annunzio, anche perché di pochi anni posteriore, come scrittura, alla Lupa. Però ebbi un’idea mica male, che incontrò l’approvazione di Ardenzi e del regista, Lamberto Puggelli. Riportarmi cioè all’archetipo della passione di una donna matura per un uomo molto più giovane . Pensai a Fedra e a Ippolito. E scelsi la Fedra di D’Annunzio, anche perché di pochi anni posteriore, come scrittura, alla Lupa.Lo spettacolo cominciava sull’aia abbastanza veristica di Paolo Bregni. Il giovane Fausto di Bella addormentato, seminudo, sulla paglia. Io, cioè Gnà Pina, cioè Fedra, che proclamava, con i bei versi dannunziani, la sua passione. La scena durava una decina di minuti. Poi la vera Lupa di Verga aveva inizio, con i suoi balli, con i suoi canti che Rosa Balistreri intonava con la sua voce antica, primordiale. Poi entravo io e recitavo, certo, con uno stile “veristico”, molto spoglio e disadorno, ma l’ombra classica di quella Fedra dannunziana era rimasta su di me, si vede, a fare da legame segreto fra la fredda trentina e l’ardente siciliana.  Quell’anno morì mio padre. Aveva 88 anni. Era sanissimo. Analisi perfette (“Le avesse lei così perfette, signora mia…” mi disse il suo medico). Di che morì? Io credo che morì di malinconia, di spleen, di umor nero. Io lo adoravo. Gli avevo chiesto per anni di venire a vivere con me, dopo la morte di mia madre nel 1975. Aveva sempre rifiutato. Il mio vecchio alpino orgoglioso e pudico. Voleva stare solo; ma era triste, era depresso, non gli piaceva il mondo che si vedeva intorno. Smise di leggere i giornali. Rifiutò la televisione. Smise di leggere i libri gialli, che gli piacevano tanto. Smise di citarmi Virgilio, che ricordava ancora a memoria: “Titire , tu patulae recubans sub tegmine fagis…” E lo recitava col ritmo esatto dei dàttili e degli spondèi. Andandosene, mi ha lasciato un grande vuoto. No, non è vero. Mio padre è l’unico, di quelli che non ci sono più, che io senta vicino ogni giorno, ogni minuto. Quell’anno morì mio padre. Aveva 88 anni. Era sanissimo. Analisi perfette (“Le avesse lei così perfette, signora mia…” mi disse il suo medico). Di che morì? Io credo che morì di malinconia, di spleen, di umor nero. Io lo adoravo. Gli avevo chiesto per anni di venire a vivere con me, dopo la morte di mia madre nel 1975. Aveva sempre rifiutato. Il mio vecchio alpino orgoglioso e pudico. Voleva stare solo; ma era triste, era depresso, non gli piaceva il mondo che si vedeva intorno. Smise di leggere i giornali. Rifiutò la televisione. Smise di leggere i libri gialli, che gli piacevano tanto. Smise di citarmi Virgilio, che ricordava ancora a memoria: “Titire , tu patulae recubans sub tegmine fagis…” E lo recitava col ritmo esatto dei dàttili e degli spondèi. Andandosene, mi ha lasciato un grande vuoto. No, non è vero. Mio padre è l’unico, di quelli che non ci sono più, che io senta vicino ogni giorno, ogni minuto.La miliardaria, di G.B.Shaw . A Londra nel 1952, avevo visto Katherine Hepburn nel ruolo del titolo. La commedia non mi era parsa granché, ma lei, lei era stupenda. Vestita divinamente da Pierre Balmain su tutti i toni del giallo, imperversava sulla scena con la sua voce un po’ nasale, e un temperamento che la fece descrivere da tutti i giornali londinesi come: “un tornado”, “un ciclone”, “un terremoto”. Io non avevo mai visto un’attrice entrare in scena con quel piglio da una porta girevole, sfilarsi i guanti (sembra facile!), buttarsi su una poltroncina, mettere i piedi sulla scrivania del suo avvocato, accendersi una sigaretta, senza smettere un attimo di parlare con la velocità di un treno. Condizionata negativamente dall’ammirazione che avevo sempre avuto per lei, la mia interpretazione fu non più che vivace, corretta, brillante. Anch’io ero vestita sui toni del giallo. Ma ahimé, non era Balmain ma Elena Mannini (in altre occasioni pregevole costumista, peraltro). Il mio ultimo costume, un pijama palazzo di raso nero con grande bavero giallo era puro orrore. In compenso i miei compagni erano deliziosi. Riccardo Peroni, spiritoso e tenero. Italo Dall’Orto, coltissimo, raffinato, cultore di Proust, conversatore incantevole. E poi Luigi Pistilli al quale ho voluto un grandissimo bene, e il cui suicidio, qualche anno dopo, mi sconvolse. A questo punto ero un po’ stanca. Queste produzioni comportavano anche lunghi giri in provincia. Un mese di prove a Roma , e poi 50, 60 “piazze” con relativi viaggi e alberghi. Circa 40.000 chilometri l’anno in macchina. Guidavo io, spesso di notte, spesso con la neve, la nebbia, il gelo. Passavo il Natale a volte in cittadine non proprio ridenti. E l’ultimo Capodanno, dopo un’orribilissima cena in un localaccio sfolgorante di luci al neon e assordato da buoni villici vocianti, a mezzanotte ero a letto, perché l’albergo non aveva nemmeno una hall, per stare un po’ lì con i miei compagni, a bere un bicchiere e farci gli auguri. Non vorrei proprio che questo suonasse vittimistico. Io adoro il mio mestiere e mi considero una privilegiata. Però ero un po’ stanca. Dissi ad Ardenzi che avevo bisogno di un anno di pausa. Per ricominciare a leggere, andare a teatro (anche e soprattutto all’estero). Uscire dalla routine per reinventarmi il desiderio del teatro. Gli scrissi: “Sì, è vero che sono stanca, ma soprattutto devo liberarmi dal dubbio che il teatro sia per me una consolazione. Devo sentirlo come una “necessità”. Quella “necessità” che ha fatto sì che gli dedicassi tutta la mia vita con gioia, con entusiasmo, con sempre nuovi tremori. Vedi, Lucio, io non voglio andare in teatro ogni sera perché non ho altro da fare. Non voglio aggrapparmi al pubblico per riceverne un calore che non ho più altrove. Il teatro non è un rifugio, non è una cuccia; è un luogo terribile, spietato e meraviglioso, dove ogni sera si mette in palio la propria vita, dove si combatte all’ultimo sangue…Spero, in questo anno di pausa, di riscoprirlo cosi.” Ardenzi capì perfettamente. Era intelligente, il ragazzo. Rimandò di un anno i nostri progetti per Le piccole volpi. Io andai un mese a Londra, un mese a New York, e finalmente mi misi a leggere Proust.  Le piccole volpi, di Lillian Hellman. L’avevo conosciuta nei primi anni ’50 nella villa di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, a Santa Marinella. Ero ospite lì con Brancati. Ricordo dei bagni stupendi, con Ingrid, le gemelle Isabella e Isotta, piccolissime, che sciacquettavano a riva con la tata, e noi che nuotavamo al largo affiancate dal pony e dal mastino napoletano. Un giorno mi ritrovai con Lillian su uno scoglio nel mare, noi due sole. Ero imbarazzata, mi sentivo inadeguata e mi limitai a sentirla chiacchierare di tutto con quella sua voce roca da fumatrice e bevitrice, molto affascinante. La ammiravo molto, come autrice e come persona. Avevo tradotto con Guerrieri la sua prima commedia : La calunnia (The children’s hour). Sapevo del suo legame con Dashiell Hammet, del suo impegno politico di liberal, vicina al partito comunista. (L’anno seguente sarebbe incappata nella “caccia alle streghe” di McCarthy, si sarebbe rifiutata di fare i nomi dei compagni, sarebbe stata iscritta nella “lista nera” e se la sarebbe passata molto male anche dal punto di vista economico). Le piccole volpi, di Lillian Hellman. L’avevo conosciuta nei primi anni ’50 nella villa di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, a Santa Marinella. Ero ospite lì con Brancati. Ricordo dei bagni stupendi, con Ingrid, le gemelle Isabella e Isotta, piccolissime, che sciacquettavano a riva con la tata, e noi che nuotavamo al largo affiancate dal pony e dal mastino napoletano. Un giorno mi ritrovai con Lillian su uno scoglio nel mare, noi due sole. Ero imbarazzata, mi sentivo inadeguata e mi limitai a sentirla chiacchierare di tutto con quella sua voce roca da fumatrice e bevitrice, molto affascinante. La ammiravo molto, come autrice e come persona. Avevo tradotto con Guerrieri la sua prima commedia : La calunnia (The children’s hour). Sapevo del suo legame con Dashiell Hammet, del suo impegno politico di liberal, vicina al partito comunista. (L’anno seguente sarebbe incappata nella “caccia alle streghe” di McCarthy, si sarebbe rifiutata di fare i nomi dei compagni, sarebbe stata iscritta nella “lista nera” e se la sarebbe passata molto male anche dal punto di vista economico).La regìa di Piccole volpi era di Giancarlo Sbragia. Era stato mio partner in Mirra, più di trent’anni prima. Un ottimo attore, raffinato, che però passava poco la ribalta, chissà perché. Molto colto, musicista, amico carissimo, spiritoso, dissacratore di classe. All’inizio ebbi difficoltà , col mio personaggio. Questa spietata calcolatrice, attaccata al denaro, che parlava continuamente di azioni, dividendi, interessi, la sentivo lontanissima da me, che non so fare il conto della spesa. A volte dicevo le sue battute senza capire bene di cosa parlasse. Ma non mi sfuggiva il lato nero, diabolico, di questa Regina Giddens, una vera dark lady , affascinante. Le trovai un tic che funzionò benissimo: nei momenti di tensione si mangiava, di soppiatto, le unghie; e guardava gli altri sempre di traverso, mai dritto in faccia. No, non ero meglio di Bette Davis che l’aveva interpretata nel 1941 nel famoso film di William Wyler, però a Regina avevo dato, meglio di lei, oltre alla malvagia avidità, una patetica e tutto sommato virtuosa aspirazione a fuggire dalle ristrettezze della provincia. Il suo “Andrò a Chicago!”, era parente, nella mia interpretazione, dell’ “A Mosca!... a Mosca!” delle Tre sorelle di Cecov. Luigi Pistilli, nel ruolo del marito Horace, onesto, scrupoloso, l’unico vero uomo in questa tana di piccole volpi voraci, fu sorprendente. Lui sì, era senz’altro più grande dell’ Herbert Marshall del film. Che bravo attore che eri, Gigi. E che uomo affascinante. Peccato che la tua fragilità e la tua ombrosità ti rendessero sempre così difficoltosi e dolorosi i rapporti con gli altri. Bisognava volerti molto bene, e io te ne volevo, per sopportare a volte le tue impennate ingiuste, o le tue improvvise lagrime sconsolate. Era come se ti sentissi perseguitato da ombre malevoli. E invece non avevi intorno che amici. Era difficile aiutarti. Però in scena eri una miniera di invenzioni, di humour, di sottintesi. A volte ti divertivi a farmi ridere, durante una scena che doveva essere molto drammatica. Tu sapevi che io non reggevo la cosiddetta “burletta”. Ti bastava uno sguardo con una speciale fiammella ironica dentro, o un’appoggiatura bizzarra su una parola, e io mi ritrovavo di spalle al pubblico, sussultante di finti singhiozzi, per nascondere la risata che mi avevi provocato. Un giorno venisti in teatro con un livido nero sul collo. Raccontasti che te lo avevano fatto cercando di scipparti, per strada, la catenina d’oro. Non era vero, purtroppo. Era stata una tua macabra prova generale di quello che accadde anni dopo a via Mozart, a Milano, quando ti trovarono strangolato nel bagno. Suicida. A causa di Milva, pare. Macchè “pare”. E’ certo. Le lasciasti perfino un biglietto. Milva non spese per te, quando la intervistarono, nemmeno una parola di tenerezza o di rimpianto. Parlò subito d’altro. Dei suoi concerti in Giappone, dei suoi successi… E il vostro rapporto durava, con alti e bassi, da anni. Non glie l’ho mai perdonato. Quando mi capita di vederla per caso in TV, cambio subito canale.  Chi ha paura di Virginia Woolf?, di Edward Albee. Bellissima traduzione, e soprattutto mirabile
adattamento di Franco Brusati. Era la prima volta che lavoravo con Mario Missiroli e, dopo un iniziale sconcerto di fronte a certi suoi milanesissimi sarcasmi, e a certi suoi cinismi di pura marca radical-chic, mi trovai a mio agio. I suoi vestiti di Caraceni, uno diverso ogni giorno, con cui veniva alle prove, mi sbalordivano. Fece una gran bella regìa. E Alberto Verso mi vestì in modo incantevole da signorazza americana di mezza età, moglie di un professore in un campus del New England. Chi ha paura di Virginia Woolf?, di Edward Albee. Bellissima traduzione, e soprattutto mirabile
adattamento di Franco Brusati. Era la prima volta che lavoravo con Mario Missiroli e, dopo un iniziale sconcerto di fronte a certi suoi milanesissimi sarcasmi, e a certi suoi cinismi di pura marca radical-chic, mi trovai a mio agio. I suoi vestiti di Caraceni, uno diverso ogni giorno, con cui veniva alle prove, mi sbalordivano. Fece una gran bella regìa. E Alberto Verso mi vestì in modo incantevole da signorazza americana di mezza età, moglie di un professore in un campus del New England. Era il mio primo incontro sulla scena con Gabriele Ferzetti. Il primo di molti. Eravamo proprio una bella coppia, in questa Virginia Woolf. Io ero sboccata, eccessiva, pateticamente disperata e in fondo fragile, come si conveniva al personaggio di Marta. E lui era un George pavido, fantasioso, crudele, pietoso, che resterà ineguagliato per molto, moltissimo tempo.  E poi Lallo, così lo chiamavamo tutti, era di una bellezza da incantare. Molto più bello ora che quando, giovanissimo, faceva i film di Soldati (La provinciale) o di Antonioni (L’avventura). E poi Lallo, così lo chiamavamo tutti, era di una bellezza da incantare. Molto più bello ora che quando, giovanissimo, faceva i film di Soldati (La provinciale) o di Antonioni (L’avventura).Un fisico asciutto, elegante, di proporzioni perfette, caviglie di razza, mani stupende. Ricordava un po’ Laurence Olivier. Lui lo sapeva, e ci marciava. Anche ora, del resto, che è decisamente più agé. Professionista fino allo scrupolo, puntuale, gran lavoratore. (E sembra, invece, che quando era un divo del cinema fosse capriccioso, spocchioso e inaffidabile, tanto che si era rovinato quella carriera con le sue mani. Lo dice lui stesso). L’unico suo difetto, in scena, era che non mi guardava mai dritto negli occhi. Un po’ più su, un po’ più giù, un po’ più di lato…Che angoscia! “Guardami, Lallo!” lo supplicavo. Niente da fare. Un po’ più su, un po’ più giù… Per timidezza, credo. Com’è frequente che i grandi attori siano timidi!  Conversazione galante, di Franco Brusati. Io ero l’unica, a cui la commedia piacesse veramente. Ardenzi nicchiava, e la produsse di malavoglia. Missiroli parlava sotto i baffi, coi suoi toni nasali, di “….una commedia che sembra una mezza minerale non gassata…”. Perché l’aveva accettata, allora? Conversazione galante, di Franco Brusati. Io ero l’unica, a cui la commedia piacesse veramente. Ardenzi nicchiava, e la produsse di malavoglia. Missiroli parlava sotto i baffi, coi suoi toni nasali, di “….una commedia che sembra una mezza minerale non gassata…”. Perché l’aveva accettata, allora?Ferzetti non aveva opinioni in proposito e si lamentava di come gli cadeva la giacca di lino. A me continuava a piacere e sopportai perfino, con una certa buona grazia, gli insulsi atteggiamenti di Sabrina Capucci. Lungo viaggio verso la notte , di O’Neill. Spettacolo che ricordo con disagio. Il testo avrebbe avuto bisogno di un sostanzioso adattamento (come aveva fatto Brusati con Virginia Woolf). La fluviale verbosità di O’Neill è insopportabile ai nostri giorni. Nessuno fece niente. Io e mia figlia Antonia ci limitammo a rivedere parola per parola la traduzione, per renderla un po’ più dicibile. Mario Missiroli si comportava, alle prove, come un ospite capitato lì per caso e malvolentieri. “Siate disadorni…sfilacciati…” diceva. Un po’ poco, come indicazione. “Questo O’Neill ….” diceva disgustato “ ha fatto bene Chaplin a trombargli la figlia Oona…” e giù un gran sorso dalla bottiglia di Ballantine che si teneva sul tavolo della regìa. Ferzetti cercava di ricordarsi di ciò che aveva fatto Ralph Richardson nel film e Olivier in teatro e annaspava incerto e poco convinto. I due ragazzi, Simoni e Bigagli, erano volonterosi e vaghi. Io ero approssimativa, mediocre, sostanzialmente infelice. Eppure lo spettacolo ebbe successo. Facemmo una lunga tournée, con buoni incassi, buone critiche, pubblico soddisfatto. Và a capire il teatro….  Giorni felici, di Samuel Beckett.
Accettai la proposta di fare questo testo con totale incoscienza. Non l’avevo mai letto. Né visto. Sapevo, a orecchio, che era un testo importante, a suo modo un cult, un must. Sapevo che ai suoi tempi l’aveva fatto Laura Adani. Sapevo che era stato un grande successo di Giulia Lazzarini, con Strehler. Bene. Giorni felici, di Samuel Beckett.
Accettai la proposta di fare questo testo con totale incoscienza. Non l’avevo mai letto. Né visto. Sapevo, a orecchio, che era un testo importante, a suo modo un cult, un must. Sapevo che ai suoi tempi l’aveva fatto Laura Adani. Sapevo che era stato un grande successo di Giulia Lazzarini, con Strehler. Bene. La regìa era di Antonio Calenda; cioè sarebbe stata alla fine di Calenda, perché i primi 15 giorni lui era ancora impegnato altrove e io dovevo cominciare a orientarmi nel testo per conto mio, in attesa dei suoi lumi. Mi lessi accuratamente il testo nella bellissima traduzione di Carlo Fruttero….e non ci capii niente. Lo lessi in francese: idem. Lessi la traduzione inglese che lo stesso Beckett aveva fatto…. lo stesso. Io ho per principio di non documentarmi mai sui testi che vado a interpretare. Non l’ho fatto per Santa Giovanna, non l’ho fatto per Maria Stuarda, limitandomi alle scarse reminiscenze storiche che ne avevo; non l’ho fatto per Anna dei Miracoli. E quando lessi che Ann Bancroft aveva girato una settimana per New York con dei cerotti sugli occhi – per provare cosa vuol dire essere ciechi – la cosa mi diede sui nervi. Anche nel caso di Giorni felici non volli leggere niente di ciò che la stampa di tutto il mondo aveva ormai detto sul testo. Mi misi davanti il copione e cominciai a fare l’analisi grammaticale (non “logica”, badate, ma grammaticale) del testo. Perché Beckett in questo caso usa il punto e virgola e non i due punti? Che significano questi puntini di sospensione? Quante volte usa la parola “dentifricio”? (le contai, erano moltissime , e ne presi nota). Perché a volte dice: “Vecchie cose, vecchi tempi…” e invece un’altra volta solo “Vecchie cose…” E così via: un lavoro apparentemente arido, quasi stupido, anche un po’ noioso. Un lavoro che dopo circa una settimana mi ripagò facendo fiorire all’improvviso, nella mia testa e nel mio cuore, il significato di tutto. Winnie non è una borghesotta logorroica che straparla a casaccio, è un’eroina in lotta con quel mascalzone di dio che tenta di piegare la sua tempra mettendola in situazioni via via più insopportabili. Quando non avrà più niente, se non una bocca riarsa che spunta dalle macerie, canterà, con un filo di voce roca ma indomata, un valzer della Vedova allegra. “Tace il labbro…” Ogni sera, a quel punto, mi veniva in mente la frase di Stendhal: “Dio ha la sola scusa di non esistere”.  Caro bugiardo, di Jerome Kilty.
Lavorai benissimo con il mio caro Pippo Crivelli. Ci unisce l’amore per la musica e per la “civiltà” nei rapporti personali. ( Una volta andai a Napoli, al S. Carlo, ad assistere a tutte le sue prove dell’ Elisir d’amore di Donizetti, protagonista Luciano Pavarotti). Caro bugiardo, di Jerome Kilty.
Lavorai benissimo con il mio caro Pippo Crivelli. Ci unisce l’amore per la musica e per la “civiltà” nei rapporti personali. ( Una volta andai a Napoli, al S. Carlo, ad assistere a tutte le sue prove dell’ Elisir d’amore di Donizetti, protagonista Luciano Pavarotti).Albertazzi era bravissimo a impersonare il bisbetico G.B.Shaw. Fra l’altro, in quel periodo, era bisbetico di suo. Io adoravo fare questa Stella Campbell, quest’attrice un po’ svenevole, un po’ “baraccona” col suo sconfinato amore per gli animali. Alberto Verso mi aveva fatto dei costumi stupendi. Il costume di velluto rosso del secondo atto, coi bordi ricamati, Alberto lo espone sempre, quando fa le sue mostre. La Campbell aveva un pechinese, Raggio di luna, per amore del quale preferì restare in Francia a fare la fame piuttosto che tornare a Londra. A quel tempo i cani dovevano fare una quarantena di sei mesi, per entrare in Inghilterra, e lei non voleva lasciarlo solo in quelle baracche disagevoli. Anch’io allora avevo un pechinese, il mio adorato, bellissimo, perfido Shanty. Quindi spesso me lo portavo in scena, con delizia del pubblico. Agli applausi finali, quando lui si piazzava sulla cappelliera al centro della scena, fra me e Giorgio, con quella sua aria di imperatore sdegnoso, gli applausi erano tali che io e Giorgio ce ne andavamo in quinta e lo lasciavamo solo, sulla cappelliera, a godersi il suo trionfo. |
 |
 |
||||
|
|||||

